Ricardo Piglia e i ponti di Cesare Pavese
agosto 27, 2020 § Lascia un commento
Ho letto questo racconto nel Teatro Sociale di Alba, nell’autunno del 2019.
Un ponte di pietra attraversato in fretta, nell’inverno grigio e piovoso della città in cui abito, di cui ho letto nei romanzi divorati in una stanza poco arieggiata, nascondiglio del lebbroso e archivio della memoria intima, privata, saccheggiata negli anni a venire e mai ripudiata. Quel ponte lo attraversa un corpo che riconosco, un viso celebrato dal lutto, dalle notti che scorrono come il fiume, dense e malinconiche.
Nel racconto che avrei voluto leggere questa sera si parla di un giovane uomo in esilio volontario, fuggito da Buenos Aires e dai suoi anni migliori. Lontano migliaia di chilometri dalla guerra sporca che verrà, dalla repressione che elimina e cancella, che tinge di sangue fresco le carceri sovraffollate.
L’argentino del racconto si chiama Emilio Renzi, che è il nome spagnolo dello scrittore argentino, che si chiama Ricardo Piglia. Quindi Ricardo Emilio Piglia Renzi fugge dalla città di Borges e Arlt per dimenticare Ines, per smettere di soffrire, e perché vuole scrivere una tesi di laurea su Cesare Pavese.
Il racconto inizia quando Emilio si trova in un dehor di piazza Carlo Felice, a Torino, in un bar di cui ignoriamo ogni particolare. Sappiamo che è mattina e che è estate. Il sole è alto, illumina le colline e i vetri iridescenti sui tavolini. Emilio è sopraffatto dai duplicati, dai visi di amici e amanti che rivede nella città sabauda. Sfiora con le dita tremanti il diario dalla copertina nera e rilegge gli appunti vergati a mano durante il lungo viaggio.
Solo chi tiene un diario può leggere il diario scritto da altri. Solo chi tiene un diario può capire il diario tenuto da altri. Solo chi scrive un diario può capire il diario scritto da altri.
Emilio pensa al romanziere come assassino, uno scrittore che compie un crimine, un suicida omicida. Riflette sul suicidio e sul crimine da risolvere.
Cerca indizi nelle opere di Pavese, cerca le piste, le tracce, i segni. Rilegge i romanzi, i racconti, le poesie come se dovessero nascondere un delitto annunciato. Questo è lo stato d’animo con cui si commettono i delitti.
Rilegge ancora il diario.
Ne Il carcere, tra i volti compatiti, nel fumo azzurrino di sigarette scagliate via, tra i corpi fasciati di cenci e la risata del mare buio, Stefano struscia la guancia sul cuscino e mormora al pallore dei vetri: “si resiste a star soli finché qualcuno soffre di non averci con sé, mentre la vera solitudine è una cella intollerabile”.
In Donne perdute, su un treno nella sera che dimentica i campi, mentre i lumi quasi pallidi cancellano il mondo, lui, Pavese, incontra una donna in una vagone di terza classe. La osserva nervoso, la guarda in silenzio, la vede fumare. Pensa alle facce sdegnose e ai sorrisi stanchi, pensa a loro, che sono vive e soffrono in silenzio, pagando per tutti.
In Amelio, un frammento, Nina e il Moschino sbucano dietro le case, oltre l’ultimo lampione. La schiuma del canale luccica e l’odore dei prati è marcio e fresco, come quando erano ragazzi. L’acqua del canale la spaventa, scompare nel sottosuolo e non si vede più.
Emilio è di fronte all’albergo Roma, sono passati vent’anni dalla fine di Cesare. Ricorda che sono trascorsi otto giorni dall’ultima parola scritta. Un corpo che attraversa la città, il ponte di pietra, il fiume sognato in agosto, l’aria calda della sera. Ripetere a se stessi un’idea che diventa un acquario con dentro un pesce. Lasciare l’acquario al freddo in una notte glaciale, su un balcone spoglio. Ripetere se stessi al mattino, prima di controllare il pesce nel ghiaccio.
Nella zona grigia, pensa Emilio, tra la terra dei morti e il mondo dei vivi, alcuni riprendono a scrivere. Chi smette ricorda i sacrifici umani dell’altipiano di Tenochtitlan. Chi riprende a scrivere vuole distruggere ciò che ha scritto perché nessuno possa leggerlo. Kafka, pensa Emilio, quando legge la lettera di Max Brod a Martin Buber. Kafka, la cenere dei manoscritti, la lettera di Pavese a Lajolo. Qualcuno ha trovato cenere di fogli bruciati nella stanza dell’albergo Roma. Cenere sul davanzale della finestra e un paio di scarpe.
Se scrivi un diario e lo bruci, forse ti salvi. Se scrivi un diario perché qualcuno, lei, possa leggerlo, ti vesti, ti togli le scarpe, un corpo nel ghiaccio, nessuna risposta. Forzano la porta.
Venti anni fa, quando ne avevo diciassette, ho sbagliato molte strade per raggiungere il territorio del gesto. Ricardo Piglia era ancora vivo e moriva di SLA, Cesare Pavese era un mistero triste, come la stazione di Santo Stefano Belbo. Sapevo che un evento può essere descritto come un referto medico, che gli oggetti ritrovati in una stanza sono prove per ricostruire un fatto.
Scoprivo, però, l’energia crescente nelle possibilità del passato e del futuro. Entravo nella messa a fuoco del presente per imparare che non tutti gli eroi greci avanzano verso la fine senza chiudere gli occhi.
Nel mio lavoro le piccole differenze si manifestano di continuo. Un libro con un refuso. Un copertina tagliata male. Come per un collezionista, so che la disuguaglianza rende unico l’oggetto. Alla fine del racconto di Piglia, un uomo, forse un conte polacco, racconta all’autore di un’unica copia del film Black Angel, un pellicola del 1946, un noir in cui Constance Dowling recita la parte di una donna uccisa con una sciarpa bianca. Quell’unica copia dura 85 minuti, dice il polacco, quattro minuti in più della versione commerciale.
Entrambi immaginano che Pavese fosse in possesso di quell’unico oggetto.
Alla fine del film, quando il corpo dell’attrice viene ritrovato senza vita, si vede un acquario con un pesce immobile, congelato.
Immaginare Cesare Pavese mentre rivede la sequenza finale è un dovere di chi scrive. Immaginarlo in una sera d’estate, da solo, la sigaretta appena accesa e il corpo ancora caldo.
Forse ricordiamo Pavese per permettergli di continuare a scrivere.
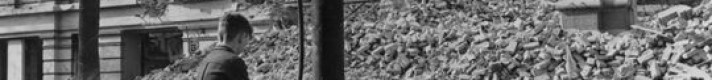
commentum, i