Qui dove non sono ancora stato
giugno 7, 2011 § 1 Commento
Qui dove non sono ancora stato
Non c’è modo di dimenticare al tramonto. Il tramonto brucia la carta che hai tra le dita, infila ripetutamente la sua luce nei tuoi anfratti acquosi. Sbircia nel passato. Muove correnti che portano la notte. Gabbiani pasciuti e ancora affamati. Porta il suono dell’acqua irrigata nei giardini, accompagna il ciabattare di uomini di mezza età, camicia sbottonata dal primo al quarto bottone, maniche ripiegate con la cura del giorno, del farsi vedere.
A quest’ora lui si mangia i denti e guarda le pieghe della birra nel bicchiere. Gli amici, una setta di romantici ubriaconi, feriti e pieni di segatura, usciti di casa da poche ore, prima che il cielo si trasformasse in un acquario tropicale.
La scorta del primo ricordo lo colpisce con un upper-cut. Il mento è perfetto. Sale. Scende. Una leggerissima scossa d’assestamento. E di nuovo la stessa posizione. La birra gialla nel bicchiere, il tramonto sulla testa profumata, i piedi nudi sul terrazzo.
Da qualche parte Dies Irae. Ovunque la terra gira e insieme sta ferma.
Non sono ancora stato qui, dice la targa che mi porto in fronte. Non sono ancora stato qui, dove dovevo andare. Dove dovevo cambiare. Le cose che dovevo cambiare non sono facili da spiegare. Il lettore ha bisogno di spiegazioni. Le richiede. Smania per averne. Tra estremi aneliti. Così il mattino dopo l’uomo guarda ancora lo stesso bicchiere, i piedi nudi sul pavimento grigio seppia, la scia del liquido giallo incrosta le pareti di vetro. Dies Irae scomparso dai timpani, ma sognato nella notte fresca. La pioggia a intervalli regolari. Grondaie gocciolanti.
L’uomo guarda il fantasma che tocca la teiera mentre lui versa caffè bollente nella tazzina sbeccata. Sbeccata. Motivetti floreali. Strisce blu. Calzini. Indossare calzini.
Così, perché il lettore lo esige, succede qualcosa. Il fantasma dice di smetterla con i ricordi, smettila con i ricordi, dice il fantasma.
Allora, su specifica richiesta appena arrivata dal settore centrale, lo scrivano appunta la sinossi:
nei dodici mesi che precedono l’epifania del tramonto accadono eventi spiegabili, fatti che si accartocciano come il cartone quando l’acqua lo invade, ma che per questo non perdono il calco del loro aspetto, anche se tempo vuole invadere lo spazio che il presente riserva al nuovo. In seguito a un incidente il protagonista perde sei anni di vita, che sommati ai sei mesi passati a rimuginare sull’incidente, fanno sei anni e sei mesi. Il protagonista cerca per settimane nello specchio punti neri da estirpare, ascolta Bruno Lauzi, divora biscotti con cereali, smette di masticare il rancore, sceglie la via comoda, quella che nelle notti estive porta sconosciuti tra le lenzuola, scivola tra le notizie di politica interna come se il suo oggi non fosse altro che uno scivolo di plastica piazzato in un giardino davanti al lago, venti anni prima.
Tutti sanno qualcosa della rotazione terrestre e tutti devono farci i conti. Alcuni sbrigano la pratica correndo. Altri stanno fermi e rimuginano. Certi leccano le ferite e provano piacere, quasi che il sangue simile a confettura di fragole di bosco.
In autunno il vento del nord graffia il marmo del Bernini e sibila sulle cupole della città spaventosa, terribile e bella come certi suicidi. I sandali dei turisti appestati di cibo economico, detto cheap in lingua straniera universale. L’amore che è tabù per gli scrittori rampanti, virus economico, cheap sui dizionari nella rete per chi avesse voglia di curiosare tra i milioni di casi dattilografati ogni giorno nei forum e sulle pagine colorate dei blog. L’amore, si dice, non bada alle funzioni decuplicate dei nostri apparati cerebrali, in soldoni se ne sbatte. Agisce e basta. Fa.
Sui sampietrini macchiati di maionese, casualmente scivolata da un panino farcito con hamburger e patatine, scarpe femminili numero 38, (scarponcini) di pelle dura ammorbidita con anni di uso stoico, lasciano l’impronta che il protagonista segue con la coda dell’occhio sinistro.
Il protagonista subisce l’assedio dello sconfitto. L’impronta che segue con la coda dell’occhio si separa dallo stampo che l’ha impressa, il corpo staccato dal segno che presto scivolerà su tutta la superficie rotulante della strada. L’uomo stacca pezzi di occhio e li lancia nel flusso a doppio senso emotivo. Donne da sinistra e da destra, donne dalla perpendicolare, donne di fronte da un portone marrone. Donne comparse come spettri e scomparse come gatti. Sconfitto perché nessuna direzione collima con l’idea confusa di strada che si è fatto. Sconfitto perché tutte le donne assomigliano a lei.
In inverno il pane riscaldato immerso nella ciotola fumante. Brodo di ceci, rosso di salsa di pomodoro e pepite piccanti che prudono sulla lingua. Il protagonista sconfitto, quello che crede nel conforto della casualità. Una donna siede di fronte a lui nell’ora in cui uomini di mezza età si infilano pantofole felpate diretti verso divani morbidi. Certe volte l’essere uomini è maledettamente ridicolo. Solo con lo sguardo, bisogna respirare. E così fa. Respira la bocca della donna. Mangiare in silenzio. Il silenzio non esiste, ma avvicina i corpi quanto basta. Le ciotole vuote, i corpi vicini dentro il letto. Stare così, anche gli scrittori rampanti possono capirlo, è come la luce del Caravaggio.
A mezzogiorno un essere lungo quanto un barattolo di capperi, stretto come l’ansa di un bastone, saltella sul terrazzo macchiato d’acqua. Di notte il fulmine sceglie alberi lontani, il freddo trasforma l’umido in verde sulle pareti. I piedi stanno bene così, sotto le coperte. Una biblioteca con scaffali lucidi di legno prezioso e non si sa che sia. Si passa di giorno e si torna al pomeriggio, prima che lampioni gialli sostituiscano il sole bianco. Routine. Abitudine di stare insieme. Muoversi in uno spazio considerando piacevole la presenza altrui. Fare del movimento altrui una coordinata essenziale. Crederci anche. Persino nei passaggi da presenza ad assenza, quando solo la voce nel telefono spiega il motivo di tanta abitudine. Buona. Calda.
Un accordo scava nelle ore di questa promessa fragile, inesistente, a essere sinceri. Le cose non vanno dette, se non in silenzio.
Fine dell’inverno. Fine del capitolo in cui il protagonista ha abiurato alla fede nella casualità. Lei parte per posti lontani. Lui piega un maglione e piange.
In primavera bisogna escogitare strategie per la difesa. La salvaguardia del custode di sangue a forma di palla da tennis bicefala. Come. Con l’otturazione dell’apparecchio fotografico di cui l’essere generico, umanamente detto uomo, è dotato dalla nascita. L’apparecchio reagisce a impulsi olfattivi. La fronda del gelsomino, il battito del ciliegio, l’elmo dell’olmo. Nei parchi non bisogna mai andare da soli. Per non morire patetici. Così bisogna reagire, con l’idiozia. I denti mostrati nell’evanescenza della cena. Aprire l’apparato digerente a ogni forma di riso. Il riso come coperta. Il riso come atto estremo. Seppellire il terrore grugnendo.
Il pezzo chiamato cuore da maestre che chiamano bambini alla lavagna, chiamato orgoglio da soldati che friggono il rammarico nel ronzio della scelta. Il pezzo tira schicchere che partono leggere come altalene e finiscono altissime nell’aria, come mani lanciate in faccia per disegnare dita. Il pezzo, quando l’estate solleva le camicie dei camerieri in piazza Navona, gorgheggia nelle bottiglie di birra sbattute a Campo de’ Fiori, il pezzo nell’estate che scende le scale con un ascensore rotto. Piogge continue. Temperatura che sale. Pioggia che spazza l’urina dai marciapiedi di piazza Vittorio. Pioggia sugli autobus mentre un satiro ordina agli oggetti di galleggiare sui cruscotti fermi al semaforo.
In questa pioggia che scende e saltella, il protagonista attraversa la città con gli occhi piccoli, stretti, come di uno che ha paura delle statue di sale.
Il protagonista, proprio come il lettore, è stanco del linguaggio ricurvo, sazio di estetica, satollo di stile, appestato di malinconia.
Gironzola sempre alla stessa ora, per piazze vuote che in poco si riempiono di voci e frasi pastose, del crick di patatine gialle. A giugno, mentre se ne sta fermo davanti a un nasone, succede qualcosa. Non ha scampo, lui. Non può fingere che quello che ha davanti non sia il suo nemico. Non è neanche un nemico. Forse è soltanto un suono.
Forse non lo è, non un suono, almeno.
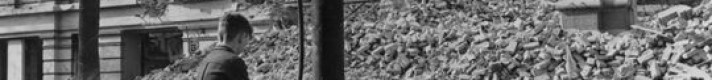

Mi hai attorcigliato le budella di piacere,allora sei anche tu dentro lo stomaco! Mi piace moltissimo questa cosa. E se fossi il tuo fantasma fumo di cuore e blu di terrore? 😛