Racconto di Natale – Storia delle suole incise
dicembre 24, 2012 § Lascia un commento
A Dora
Ed eravamo nella piena di un’inondazione terribile o davanti a una cascata in miniatura, in uno di quei parchi in cui i prati sono fatti di fili sintetici verdi e agli angoli uomini vestiti di giallo vendono fotografie per qualche moneta di rame. Eravamo fermi e non lo eravamo, come nei sogni in cui siamo noi e non lo siamo, come quando un corpo si avvicina e unisce le traiettorie dello sguardo e dice qualcosa o gesticola soltanto, mentre è talmente vicino da sembrare solo uno spettro di corpo, e arricciamo le labbra perché ci fa sentire strabici o soltanto stanchi o persino morti o arrangiatevi voi.
Eravamo nelle piazze che riproducevano quadri di nature morte in cui i gatti e le fontane assaltavano il mercato, e a nessuno veniva in mente di abbassare lo sguardo.
Eravamo così vicini all’inondazione terribile da non riuscire più a vederci. Eravamo solitari e tristi e spenti e con i mozziconi freddi nelle pattumiere.
Eravamo senza marmellata e guardavamo servizi televisivi in cui qualcuno seguiva qualcuno. Eravamo talmente giovani da sembrare scemi.
Perdevamo e ci perdevamo tutto.
Nessuno saltava nei fiumi.
Nessuno saltava nel fiume per dire, e ora?
Eravamo fermi alle fermate indolenzite dalla neve e dalle buste dei cinesi e dai pacchi dei pakistani, ed eravamo schiacciati tra i pensionati in fila alla posta, in fila alla banca, in fila alla mensa, in fila al cimitero, in fila sui marciapiedi dove i bambini non camminavano più, perché li avevano segregati nelle case brutte con i televisori brutti con le cose facili che cancellano la vita.
Eravamo fermi e lo sapevamo. Non eravamo stupidi. Sembravamo scemi ed eravamo giovani.
Qualcuno si slogava il naso cucinando e qualcuno diceva precario, precario, precario.
Qualcuno sorrideva ai fiumi visti nei film americani e qualcuno diceva, voglio la guerra, voglio la guerra con il sangue in resta.
A qualcuno piaceva parlare di elezioni e di facce da elezioni e di cose da elezioni tipo la simbologia elettorale o tipo il minutaggio delle comparsate dei politici o tipo le domande senza raschietto dei giornalisti alle conferenze stampa dei potenti o dei potenti alle conferenze stampa della fine delle cose come le avevamo conosciute.
Eravamo sterili perché non potevamo avere figli ed eravamo fertili perché i nostri nonni avevano allattato con la guerra e con i semi bombardati dagli anglo-americani e perché pochi di noi conoscevano la fame e perché quelli che la stavano conoscendo non erano contenti per niente.
Gheddafi era morto in diretta e Saddam Hussein era morto in diretta e anche Osama bin Laden era morto in diretta. Persino il papa era morto in diretta. Erano tutti vivi in diretta e aspettavano i morti per dire che loro c’erano, c’erano stati e ci sarebbero stati.
Dicono che eravamo soli ma non era vero.
Eravamo terrorizzati.
Parlavamo di uomini eccezionali che avevano fatto cose eccezionali in epoche eccezionali.
Dicevamo che per uomini intendevamo dire donne e uomini.
C’era la fretta di dire le cose per fermarle. Ce le strappavano continuamente. Ce le dicevamo addosso, le cose. Dicevamo le cose per non urlare, per non correre negli angoli bui e piangere latte versato sull’inchiostro scaduto. Eravamo appesi alle palizzate davanti ai castelli dei feudatari, con le cinture smunte dalla rabbia, gli occhi tonanti e le gole infiammate. Guardavamo i vecchi feudatari nei loro castelli e ci dicevamo che prima o poi sarebbero tutti morti. Ma non era vero. E lo sapevamo.
Eravamo i più democratici e i più stupidi, perché conoscevamo le ingiustizie della democrazia.
Eravamo i più colti e i meno arrapati tra i barbari che avevano consumato le bandiere e le trombe e le parole patriottiche che a noi facevano schifo perché così era.
Eravamo divisi tra i padri che amavamo come padri e guardavamo come estranei.
Eravamo quelli che dicevano, dovete rubare i libri, ed eravamo sciolti nelle strade, fermi agli angoli delle piazze, a coprire panchine inesistenti, con le mani sulla copertina delle lettere di Cortázar, e sussurravamo nomi di impenitenti, nomi di poeti senza barba e nomi di scrittori con la lingua ocra.
Eravamo quelli che avevano intravisto la lunga sgommata dell’ironia, e sapevamo che a una botta corrisponde una pausa, e che a una pausa corrisponde una paura.
Eravamo stanchi di Dickens e dei consigli di lettura di Baricco. A Natale regalavamo arance in salsa rosa e a qualcuno di noi veniva lo scorbuto. Eravamo ubriachi o con i polmoni verdi o con le gengive retratte. Viaggiavamo su treni che portavano in stazioni lontane, in posti freddi, con parole in cirillico sulle fermate, sulle strade sconosciute delle città appartenute a biografie immaginarie.
Eravamo sempre nella carta, fermi su qualche pagina con la matita sbeccata.
Eravamo stupidi ed eravamo affamati. E non volevamo il potere. Volevamo solo nasconderci. Coprirci per non sentire freddo. Mangiare per non avere fame. Parlare per non avere dubbi.
Eravamo in una stanza al piano terra. C’era una vecchia. Era vestita di giallo. Aveva lunghi orecchini e una collana di rame. C’era la vecchia che ci guardava, mentre la stanza diventava fredda e un odore di freddo e rame entrava con gli spifferi bianchi dalla porta socchiusa. Eravamo nella stanza con la vecchia vestita di giallo. La vecchia apriva la bocca. La apriva per dire che era ora di andare, o che era ora di restare. La vecchia apriva la bocca e si mordeva le labbra. Labbra di vecchia ammorbidite dal vento. Il fiato della vecchia era una storia di scarpe. Disse la vecchia. La storia delle mie scarpe, questa è la storia di Natale.
Eravamo infreddoliti, nella stanza sempre più fredda, con la vecchia che stava per raccontare la storia delle scarpe. Diceva la vecchia, a Natale del 1995 ero meno vecchia di oggi. Una vecchia che era stata miope fino ad allora, ero in quell’inverno vicino. Avevo perso la trasparenza del cristallino. Avevo le cataratte. Feci come mi dissero. Mi operarono. La trasparenza del cristallino era una cosa incredibile. Avevo di nuovo gli occhi e avevo perso la miopia. I colori sono la cosa che ricordo meglio. A Natale del 1995 mio marito era morto da sei mesi. Sarei andata a pranzo da mia figlia. Suo marito era vegetariano e aveva in mente di fare la pizza. La pizza a Natale, come idea, mi piaceva. Mia figlia mi disse di non fare regali ai bambini, non ce n’era bisogno. Dissi a mia figlia di non preoccuparsi. Poi accesi il televisore e mi addormentai. Mi svegliai verso le tre del pomeriggio. Era il 24 dicembre. Fuori, per strada, vedevo cappotti e pellicce e sciarpe e buste da regalo. Non so perché, ma mi venne in mente la guerra. L’odore del Natale di guerra. E mi vestii. Avevo freddo al collo e alle caviglie. Ma decisi di uscire. Così feci il giro dell’isolato. Arrivata al portone di casa mia, lo feci di nuovo. Pensai a mia figlia, alla pizza, ai bambini. Pensai a un regalo, alla guerra, al sogno che credevo di non ricordare. C’era un ciabattino, poco prima dell’angolo. Aveva gli occhi verdi e parlava troppo poco, per essere un artigiano. Entrai e gli dissi che avevo bisogno di un regalo. Gli dissi che avrei voluto calpestarlo tutti i giorni, quel regalo. Lui disse, certo. Tornai a casa e presi le scarpe estive, quelle invernali e quelle autunnali. Tornai dal ciabattino.
Questa è la storia della vecchia che fece incidere sulla suola delle scarpe il nome di un uomo che odiava. Quell’uomo era Silvio Berlusconi.
Noi, questa storia, non l’abbiamo ancora capita.
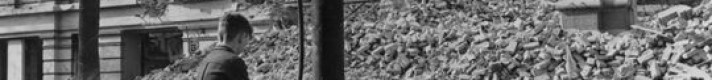
commentum, i