Jim Colder
dicembre 13, 2010 § Lascia un commento
Jim Colder
Gli Studios sono sul lato opposto della strada. I pioppi hanno la corteccia macchiata, sono malati, e fra un po’ verranno a dargli l’estrema unzione. Siedo nel bar dove siedo ogni mattina da 35 anni. Da quando vengo a fare colazione qui ho visto 12 barman, 28 camerieri, tre gestori, 6 insegne, due monete. La strada invece è rimasta intatta. Lo stesso asfalto, la stessa gioielleria all’angolo, la fontana in fondo, i palazzi primo novecento. E’ rimasto com’era, questo pezzo di Roma.
In genere inizio alle 9, ma può succedere che mi convochino anche alle 7:30. Se non ho molte scene posso staccare alle 13. Dopo la pausa le riprese possono durare massimo sei ore. Sono un attore. Il mio nome è Jim Colder. Sono nato a Boulder, in Colorado, nel 1936.
Mia madre era spagnola, mio padre di Boulder, Colorado. Quando la madre di mia madre venne a trovarci, disse «che cazzo, qui è più freddo della morte». Mio padre rispose «è vero, vecchia, dovresti uniformarti».
Da piccolo giocavo nella squadra di baseball. Mio fratello maggiore, Al, allenava quel branco di ragazzini foruncolosi che ogni domenica mattina uscivano in calzettoni grigi per sfidare il ghiaccio, più che la gravità. Mio fratello Al aveva un motto, che gli piaceva ripetere prima delle partite: «in culo ai freddolosi». Allora noi, della squadra dei Grey, ci mettevamo in cerchio e con tutta la saliva che avevamo gridavamo in coro «in culo ai freddolosi».
Al lavorava con mio padre all’officina dei treni, in uno dei magazzini che facevano da scia alla stazione ferroviaria. Quando tornava a casa si lavava mani e faccia nel catino, con l’acqua che mia madre mi ordinava di caricare dal pozzo. Poi si sedeva a tavola, fingendo di leggere il giornale della sera. Guardava la combinazione delle lettere, più che altro. Gli piacevano molto le lettere, ma non aveva mai avuto fortuna con l’alfabeto. Mia madre mi faceva un segno e io apparecchiavo per quattro persone. Ma non aspettavamo mai mio padre. Lui aveva da lavorare fino a tardi. Finito di mangiare, Al mi accompagnava in camera: mentro indossavo il pigiama, lui fumava una sigaretta espirando con la bocca a uccellino dalla finestra, perché nessuno doveva sapere che lui fumava; dopo aver tirato una schicchera al mozzicone, facendolo scintillare sul prato come una lucciola, si sdraiava sul suo letto e iniziava un racconto; era la storia di tutti quelli che passavano dalla stazione di Boulder, giorno per giorno.
Mia madre era una donna molto coraggiosa, per aver sposato uno come mio padre. Lui era povero, senza una casa, orfano senza famiglia, con pochi denti buoni, per lo più doloranti. Si erano conosciuti alla festa delle mele, su un barcone galleggiante sul fiume Potok. Mia madre era arrivata due mesi prima da Santiago: s’arrangiava come ballerina nelle bische, leggeva tarocchi, fondi di caffè, serviva ai tavoli,e via dicendo. Mio padre le aveva chiesto di ballare, così si era formata la famiglia. Al era nato per primo, io per secondo. Quell’anno le cose peggiorarono, perché la Depressione si era manifestata tutta: i capo-cantieri assumevano a giornata, scegliendo volta per volta i corpi più robusti; chi mangiava poco, chi tremava per il freddo, veniva scartato. Le fabbriche chiudevano. Il campo da baseball dove mio fratello era famoso, tant’è che lo chiamavano tutti l’Osso, s’era svuotato. I ragazzini seguivano i padri con la speranza di trovare qualcosa per la giornata. Perciò il 1936 non fu un buon anno per nascere.
Mi hanno raccontato così tante volte la storia di quegli anni che ho l’impressione di ricordarla con gli occhi, come uno che l’ha vista sul serio, l’America povera, disperata.
Un anno terribile anche per la nostalgia di mia madre, che non tornava in Spagna da molto tempo. Il Generale Franco aveva scatenato una guerra, e l’alleanza nazi-fascista-nipponica che lo appoggiava era troppo potente per le forze volontarie che affluivano da tutta Europa e oltre. Così gli oppositori iniziarono a mangiarsi tra di loro, come gli scarafaggi: socialisti e comunisti si misero a sparare sugli anarchici. In questo modo mia madre perse tre fratelli.
Dresda e Hiroshima erano città bruciate, quando ho compiuto 9 anni. Mio padre e mio fratello Al avevano ripreso il lavoro all’officina dei treni come saldatori e operai specializzati. Il campo da baseball, a un isolato da casa nostra, si era ripopolato. La squadra dei Grey ululava finalmente il motto del Gelo coniato da mio fratello. Mia madre, poi, aveva trovato un impiego a mezza giornata nella scuola di Francisco, un esule spagnolo: davano lezioni di ballo alle coppie del quartiere. Mio padre, che non odiava nessuno al di fuori di sé stesso, lui lo odiava: non gli piaceva che mia madre si stringesse per quattro ore al giorno, esclusi i festivi, a quel filo di terra spagnola, asciutto, scavato, che era un pulsare di muscoli a fior di pelle.
– Ti piace quell’acciuga, vero?-, diceva mio padre.
– Sì, mi piace-, rispondeva mia madre.
Litigavano tutti i giorni per la storia dell’impiego alla scuola di ballo. Se Francisco non fosse stato spagnolo, probabilmente le cose sarebbero andate comunque nella direzione in cui andarono. Ma il fatto che lo fosse faceva impazzire di gelosia mio padre.
– Cos’hai in quella borsa?-, chiedeva mio padre, con la faccia nascosta nel buio.
– Un vestito nuovo-, rispondeva mia madre, truccata e vestita per uscire.
Lei aguzzava lo sguardo, a quel punto. Stringeva la maniglia della porta di ingresso e usciva. Quando tornava,mio padre si faceva trovare nello stesso punto in cui l’aveva vista uscire.
– Te l’ha regalato lui?-, le chiedeva, con la faccia sempre più immersa nel buio.
– In un certo senso.-, gli rispondeva mia madre.
– Ti piace quell’acciuga, vero?-, biascicava per rabbia, mio padre.
– Sì-, rispondeva lei, – sempre di più.
Nel 1954 presi la decisione della mia vita. Preparai una borsa con due vestiti, chiesi a mio padre un biglietto di sola andata per New York, accettai di buon grado il suo rifiuto, lasciai la squadra di baseball, risposi con un pugno, quando Al mi accusò d’essere un vigliacco, incassai i suoi calci con la dignità di mia madre, scrissi una lunga lettera e la indirizzai a Francisco Fuentes, lo sfasciafamiglie, sapendo che mia madre l’avrebbe letta per prima, poi chiusi la porta di casa borbottando «in culo agli spagnoli».
Mi chiamo Jim Colder e faccio l’attore da trentacinque anni. Vivo a Roma, in Italia, e interpreto un ruolo variabile da tutta una vita. Non il cattivo e neanche il buono. Non il brutto, non il bello. Non lo spietato, crudele, né l’eroe o il fortunato. Il mio ruolo consiste in due, tre battute, dette in inglese italianizzato. I personaggi che interpreto stanno tutti alla stazione: ho fatto il bigliettaio, il controllore, l’uomo delle pulizie, il barbone, l’amante, il soldato, la spia, il passante, il vicino di posto, il meccanico, il venditore ambulante, il giornalaio, l’uomo degli avvisi, il portantino. I miei personaggi non hanno carattere. Si trovano dove si trovano perché ci si trovano. Non hanno scelta. Mentre la trama scorre loro camminano, parlano, mangiano, vendono, sbuffano, ridono, baciano, piangono. Sono uomini essenziali, nessuno li ricorda, ma fanno parte del mosaico. Sono la vita che vivete quando non siete al cinema, quando aspettate il treno, quando lo attraversate per cercare un posto. Non importa che lingua parliate per capire l’umanità che ho spremuto in quegli uomini. Sono fatti della materia di cui sono fatte le stazioni.
Da trentacinque anni vengo in questo bar. Qui consumo la mia pausa pranzo, guardo i passanti dal vetro, ascolto le sirene delle ambulanze, cose così. Mangio quasi sempre un’insalata, due fette di pane, e bevo una birra. Gli Studios sono sul lato opposto della strada, quindi aspetto seduto fino all’ora di apertura.
Ma oggi è un giorno diverso. Stamattina, prima di iniziare le riprese, Giorgio, il direttore di produzione, mi ha chiamato nel suo ufficio.
– Come stai?-, chiede Giorgio, che siede dietro la scrivania di formica.
– Come al solito, il medico dice, ci sono dei miglioramenti, ma non gli credo-, rispondo. Poi sfilo una sigaretta dal taschino.
– Ho una brutta notizia-, dice Giorgio, guardandomi intensamente.
– Cos’è, hanno tagliato il film?-, gli chiedo con l’aria di uno che sa bene come vanno queste cose. E accendo la sigaretta.
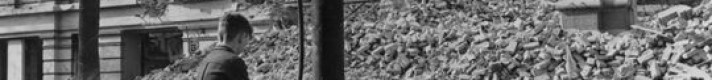

commentum, i